Speciosa Imago
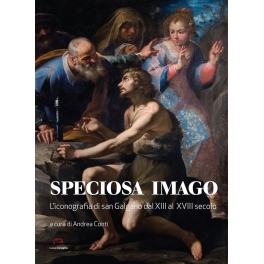 Ingrandisci
Ingrandisci L'iconografia di san Galgano dal XIII al XVIII secolo
- Autore: Andrea Conti
- Anno: 2014
- Formato: 21 x 28 cm.
- Pagine: 175
- ISBN: 88-7145-331-6
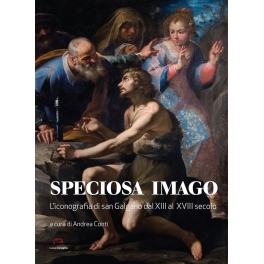 Ingrandisci
Ingrandisci L'iconografia di san Galgano dal XIII al XVIII secolo
Ritengo particolarmente lodevole l’iniziativa della pubblicazione degli atti del convegno sull’iconografia
di san Galgano che si è svolto a Chiusdino nel maggio 2013: è senz’altro un significativo
contributo per la conoscenza di un culto tanto antico ma che è stato recentemente “inquinato” da leggende
e persino da ipotesi interpretative troppo spesso fantasiose legate a quella “spada nella roccia” e
che, messe in relazione con re Artù e con la ricerca del santo graal, hanno dato origine anche a strane
pratiche esoteriche.
In realtà, nello studio dell’agiografia, il nostro santo è importante particolarmente per essere stato oggetto
del più antico processo di canonizzazione del quale ci siano pervenuti gli atti e la cui celebrazione è dagli storici
concordemente collocata nell’agosto del 1185: essi ci narrano peraltro solo alcuni elementi essenziali della
sua vita e soprattutto i miracoli seguiti alla sua morte quando, in assoluto contrasto con la sua breve vita eremitica
di totale nascondimento, la sua tomba a Montesiepi vide uno straordinario afflusso di fedeli.
Fino a quella data erano stati i vescovi, dietro richiesta insistente dei fedeli, a innalzare sugli altari le reliquie
venerate dei martiri e dei confessori della Fede autorizzando la venerazione di coloro che in vita e in morte avevano
testimoniato in grado eroico la fede, soprattutto dopo la manifestazione di miracoli attribuiti alla loro intercessione.
Come esempio analogo di quel tempo, per il nostro territorio, sono da ricordare sant’Alberto da Chiatina
(†1202), santa Fina di San Gimignano (†1253), san Lucchese di Poggibonsi (†1260), il beato Giacomo da
Montieri (†1289), il beato Bartolo di San Gimignano (†1300) e il beato Antonio di Monticiano (†1311): le
loro storie, vissute nella sofferenza e nel nascondimento, divennero esemplari proprio con la dimostrazione
dei prodigi avvenuti dopo la loro morte, e il loro culto popolare ab immemorabili venne riconosciuto dalla
Chiesa solo diversi secoli dopo.
Fu proprio con Alessandro III (1158-1181) che, seguendo il precedente tentativo di Gregorio VII (1073-
1085), si fece strada gradualmente la necessità di regolare tale situazione con la garanzia di un più accurato riconoscimento
pontificio. Durante il suo lungo pontificato ricevette infatti dodici richieste di canonizzazioni:
di esse, solo cinque ebbero un esito favorevole.
Presumibilmente l’indagine pontificia nei riguardi di san Galgano fu dovuta anche al fatto che la fase
terminale della sua vicenda terrena si sia svolta durante il papato del senese Alessandro III e dell’immediato
successore, il lucchese Lucio III (1181-1185) che erano certamente informati sull’importante fenomeno
dell’eremitismo toscano di quel tempo.
L’inizio dell’esperienza ascetica di Galgano ha una certa analogia con quella di Francesco d’Assisi che nel
1205, dopo una visione a Spoleto, decise di abbandonare l’ideale cavalleresco per una vita di penitente e di
eremita, prima di dare inizio a quello che sarebbe diventato l’ordine dei Frati Minori. L’esperienza eremitica
di Galgano è racchiusa in appena undici mesi – dalla vigilia del Natale del 1180 alla fine di novembre 1181
– con una vita solitaria a Montesiepi, interrotta con frequenti visite agli insediamenti dei Guglielmiti e con
una visita ad pedes domini papae (se a Roma o altrove, è oggetto di dibattito storiografico).
Una vicenda breve e abbastanza normale in quei tempi. L’episodio che più aveva destato scalpore e meraviglia
era stato proprio quella “spada nella roccia”, infissa da Galgano da Chiusdino nel 1180 sulla sommità del
Montesiepi: gesto che lo caratterizzò nell’iconografia e che attrae ancora tanti pellegrini e visitatori.
Un gesto che ha attraversato i secoli e sta lì ancora a indicarci una scelta di radicalismo evangelico che va
meditata, non tanto come un enigma misterioso, ma come messaggio di pace.